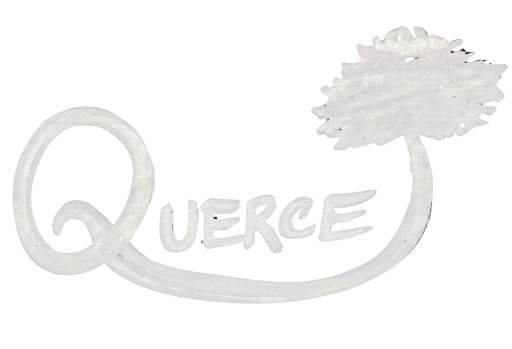Noi resistiamo
Distruzione del verde: la vera storia di una foresta scomparsa
- Home
- Distruzione del verde: la vera storia di una foresta scomparsa

Distruzione del verde: la vera storia di una foresta scomparsa
di Alfredo Sanapo – – –
INTRODUZIONE
Il poeta salentino di punta, Vittorio Bodini, con i versi profetici della sua lirica è arrivato dove gli altri non potevano arrivare con la pragmaticità spicciola tipica del luogo. E purtroppo aveva ragione quando scrisse senza parafrasare che “sulle pianure del Sud non passa un sogno“. Evidentemente la sua innata sensibilità gli svelava non solo l’incubo incombente ai suoi tempi, ma anche la condanna odierna e, con molta probabilità, quella futura alle quali rischiano di condurci alcune nostre insensate scelte.
È pur vero che oggi come non mai cambiamenti climatici, calamità naturali, politiche dissennate di infrastrutturazione selvaggia e comportamenti errati e criminosi di stampo piromane e boschicida stanno materializzando l’angoscia di un Salento sempre più brullo e arido. Questa per sfortuna non è cronaca degli ultimi decenni e di quelli a venire, bensì una questione storica da ricercare soprattutto nella svolta verso le monocolture e nelle scelte nella gestione del post-latifondismo. La frammentazione dei boschi dovuta ad usi civici sempre più parcellizzati e, quindi, meno coordinati e razionali, ne ha causato l’inevitabile decadenza.
MONOCOLTURA: UNA SCELTA SBAGLIATA?
Molti individuano la ragione dell’attuale ed evidente distruzione del paesaggio verde ai recenti incendi, ai disboscamenti e alla vicenda della Xylella. Però, le cause effettive sono più remote e profonde e vanno ricercate nel “peccato originale” che ha portato a sacrificare la biodiversità presente nella nostra terra in nome delle – ormai considerate “tradizionali” – monocolture: ulivo, vite e grano. Per dimostrare questi miei enunciati, è opportuno fare un salto nel passato del Salento, un tempo terra di boschi, boscaglie, macchia e gariga. L’ambiente naturale della Penisola salentina, infatti, da tempo sottoposta a diffusa ed intensa antropizzazione, assoggettata dalla speculazione edilizia e solcata da una fitta rete stradale, “…in tempi remoti […] era tutta coperta di boschi di querce…” (Cosimo De Giorgi, 1884). D’altronde, il nome stesso del nostro capoluogo non mente e rimanda direttamente ad una particolare classe di querce, il leccio (Quercus ilex).
LA FORESTA PRIMORDIALE: UN PARADISO PERDUTO
Al fine di evitare retorica e alienazione dalla realtà, tenterò di spiegare le mie asserzioni facendo riferimento concreto alla disintegrazione dell’ex polmone verde del Sud-Salento, il Bosco Belvedere, a sua volta uno dei tanti residui della primordiale Grande Foresta Salentina che, con le dovute differenze in proporzione e funzione, era assimilabile all’Amazzonia per il Brasile con la quale peraltro condivide un infausto destino. Essa occupava gran parte della provincia 80.000 anni fa, al tempo in cui l’Homo Neanderthalensis sopravviveva con ciò che la selva poteva offrire. Il primo assalto a questo paradiso terrestre si verificò circa 20.000 anni fa ad opera dell’Homo Sapiens che iniziò a sfruttarlo con le primitive pratiche agricole e i primi villaggi. Poi arrivarono le civiltà dei Messapi, di Greci e Romani che con le loro città, strade, acquedotti e fortificazioni diedero un ulteriore colpo all’area silvestre. Fino al XIV sec. la Grande Foresta di Lecce, “si estendeva ancora per 75 km lungo il litorale adriatico salentino procedendo da Nord a Sud, tra la località Fontanelle (BR) e la periferia settentrionale di Otranto, spingendosi al suo interno e comprendendo anche pascoli e paludi” (Mainardi, 1989). La crescente attività umana, i ripetuti incendi, la sempre maggior richiesta di aree da destinare all’agricoltura ed al pascolo e di legna da ardere, portò ad un’intensa opera di disboscamento ed al progressivo ridimensionamento della primordiale foresta. Così, l’originaria copertura vegetale si franmentò a creare altre più piccole aree boschive, come ad es. l’Oasi di Torre Guaceto a Brindisi, l’Oasi delle Cesine a Vernole, la Foresta di Rauccio a Lecce, Il Bosco di Tricase e, appunto, il Bosco Belvedere.
BOSCO BELVEDERE: STORIA DI UNA DISTRUZIONE
Quest’ultimo era un grande bosco plurimillenario risalente al periodo post-glaciale al cui interno attualmente ricade una vasta zona adesso nota col toponimo di “Paduli“: una fascia quasi ellissoidale spessa in media 1 km che si estende da Cutrofiano a Specchia de’ Preti. Verso il bosco, un tempo esteso circa 7.000 ha e ricca di vari ecosistemi (bosco, gariga, paludi, stagni e macchia mediterranea), ancor oggi giungono le acque provenienti dalle vicine serre tramite ramificati canaloni, spesso fiancheggiati da una folta vegetazione.
Numerose ricerche storiche e archeologiche, condotte dal prof. Paul Arthur, suggeriscono che questa grande selva è stata per millenni fonte di sostentamento per le popolazioni che vi vivevano a ridosso: a supporto di ciò la scoperta di un villaggio del VI-VII sec. d.C. in località Scorpo presso Supersano (Arthur, Fiorentino, Imperiale, L’insediamento in Loc. Scorpo-Supersano, Archeologia Medievale XXXV, 2008, pp. 365-380). Nel fitto bosco prosperavano il prugnolo, il corbezzolo, il perastro, l’apuzia, il sorbo, il nespolo locale, il melo e la vite selvatica e vi trovavano asilo volpi, lepri, conigli, tassi, istrici, ricci, faine, martore, puzzole, lupi e cinghiali.
Alcuni documenti storici attestano ancora l’esistenza della denominazione Bosco Belvedere nel 1476 nell’inventario del feudo di Supersano redatto per i Principi Gallone di Tricase, ai quali appartenne per quasi 3 secoli (in precedenza fu dei Castriota, baroni di Parabita). Questo immenso latifondo di querce (il leccio, il farnetto, la roverella e la virgiliana) includeva anche olmi, castagni, carrubi, frassini, carpini bianchi e piante e fiori del sottobosco e della macchia mediterranea (alloro, lentisco, mirto, viburno, pungitopo, rosmarino, gelso, rose di S. Giovanni). Il bosco garantiva cospicue rendite per gli usi concessi dai Principi mediante il pagamento dei diritti di “fida” (concessioni per pesca e caccia; raccolta di frutti e legna, giunchi e canne palustri; coltura di lino e canapa; produzione di carbone, di erbaggio per ovini e bovini e di ghiande per i maiali; uso di erbe a scopi medicinali).
Dai primi anni del ‘700 fino alla metà dell’800 questa antica riserva naturale si restrinse sino a quasi estinguersi per dar spazio alle colture. La famiglia Gallone mantenne la proprietà della foresta fino al 1861, allorché il nuovo Stato Unitario impose loro la cessione di buona parte della foresta ai Comuni di competenza territoriale (Botrugno, San Cassiano, Maglie, Miggiano, Ruffano e Specchia). L’area boschiva fu ripartita tra i comuni che ne esercitarono gli “usi civici”, con assegnazione dei lotti ai rispettivi municipi dopo una lunga disputa con la famiglia detentrice.
Ciò diede inizio all’inesorabile distruzione del bosco e, in pochi decenni, quanto sopravvisse agli incendi e ai tagli illeciti, venne eliminato per far spazio alla cultura arborea emergente: l’ulivo. Nel 1864, lo studioso Raffaele Marti (L’estremo Salento, Lecce 1931, pp. 21-23) scrisse che “il bosco era ridotto quasi a metà”.
“Non è senza il massimo dolore” – affermò Cosimo De Giorgi nel 1877 – “ch’io osservo di anno in anno cadere atterrate al suolo quelle querce maestose che hanno sfidato per tanti secoli le ingiurie del tempo, dell’atmosfera, degli uomini e degli animali. La falce e la mannaia livellatrice del boscaiolo segnano intanto, inesorabili su questa via di distruzione”. “Era questo forse” – osservò Giacomo Arditi (Corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, rist. an. Lecce 1994, p. 65) nel 1879 – “nella Provincia il bosco più vasto e vario per essenze arboree, ma oramai non rimangono più di arbustato e di ceduo se non poche “moggia” a Nord-Ovest verso Supersano; tutto il resto è ridotto a macchia cavalcante od a terreni coltivati a fichi, vigne e cereali”.
Agli inizi del XX sec. la zona fu interessata da opere di bonifica allo scopo di eliminare la piaga della malaria, per cui molte aree paludose, pur rappresentando un’importante risorsa per l’economia delle popolazioni, furono interessate da drenaggi e opere per lo smaltimento delle acque stagnanti. Circa 30 anni fa, il territorio ha subito un’ulteriore impatto antropico a causa della distruzione indiscriminata di alberi per creare parchi eolici e fotovoltaici e del crescente interesse turistico con lo sviluppo di una serie di villaggi e stabilimenti balneari che, collegati da strade e sentieri, hanno ridotto ai minimi termini le poche tracce rimaste dell’antica selva.
PADULA MANCINA: ISOLA DI BIODIVERSITÀ
Attualmente restano poche “isole’ dell’appena descritto scrigno di biodiversità e naturalezza, quantificabili ad appena l’1,3% della superficie agraria boscata, detenendo uno degli ultimi posti nelle graduatorie relative alle aree boschive. Una sorta di campione rappresentativo di questo sterminato paradiso perduto si trova nel comune di Montesano Salentino sotto il nome di “Padula Mancina” ma solo nelle stagioni piovose. Qui infatti ha sede uno stagno d’acqua effimera di interesse comunitario, ora divenuto simbolo di un progetto di rinascita idrica del territorio perché oasi umida e ombrosa, ricca di biodiversità (alcune specie sono esclusive) e pertanto sito di foraggiamento degli uccelli migratori.
CONCLUSIONE
Per avere idea di quello che abbiamo perso, bisogna concepire la foresta primordiale del Salento come l’unione continua di migliaia di cloni del sito Padula Mancina, da S.M. di Leuca a Torre Guaceto. Partendo dall’originaria entità boschiva per arrivare all’attentato perpetrato alla sua integrità da parte dei fattori temporalmente più recenti, si evince chiaramente che essi costituiscono soltanto la punta dell’iceberg di una lunga serie di ferite mai rimarginatesi non solo più antiche, ma anche più ampie e gravi. L’agricoltura, l’allevamento, le civiltà susseguitesi (e le loro infrastrutture), lo sviluppo industriale, la fine del latifondo e le politiche antropocentriche, nel corso dei secoli, hanno ridotto al lumicino la biodiversità. Essa ha subìto il colpo di grazia con l’adozione dell’ulivo come coltura verde quasi esclusiva in quanto ne ha incrementato la vulnerabilità: un solo batterio patogeno specifico per quella cultivar è bastato a distruggere quasi tutta la copertura fogliare. È dunque ragionevole pensare che la vicenda Xylella sia stata la ciliegina su una torta già avvelenata dai comportamenti di classi politiche sempre più guidate dal consenso e dall’interesse personale e lobbistico ché dal buon senso e dalla volontà di lasciar vivere la natura come opportunità per i posteri.
- Share