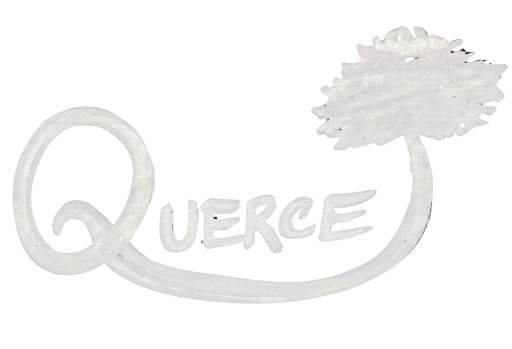Noi resistiamo
Il circo decadente e sovversivo, come l’Europa*
- Home
- Il circo decadente e sovversivo, come l’Europa*

Il circo decadente e sovversivo, come l’Europa*
di Alfredo De Giuseppe – –
Il circo che arriva nella provincia è stato sempre di seconda categoria, di piccole dimensioni, con un cast artistico alquanto limitato. Però negli anni del secondo dopoguerra era sufficiente per alimentare sogni di libertà, di esagerata attività artistica immersa nella natura animale, dove le bestie finivano per essere umanizzate e trasformate in intelligenze indotte al divertimento. Il circo, un gioco di abilità variopinte, ammirate da tutti, utili per infiammare infine le menti dei bambini. In una terra che vedeva pochi spettacoli, dedita al duro lavoro e alle sole feste patronali, il circo era comunque un avvenimento. I grandi circhi facevano altri giri, avevano altri target.
Ancora oggi, qui nella desertificata terra di sud est, arrivano i piccoli circhi, quelli che cercano di mantenere una loro dignità, dove si intuisce con estrema evidenza la povertà di fondo. In questi giorni, per strappare due foto, due immagini intense, ho seguito per un po’ il circo “Marina Orfei” che è stato prima a Ugento, poi a Tricase e a Botrugno. Marina Orfei, imparentato con la famiglia Monti, è uno dei tanti Orfei che circolano nel mondo circense, ce ne sono almeno una ventina che fanno riferimento a quel cognome.
La sua prima visibilità è ferma al semaforo d’ingresso alla città. Un ragazzo indiano distribuisce piccoli biglietti con le indicazioni degli orari dello spettacolo. Il ragazzo non conosce nessuna parola italiana, gli si può chiedere qualsiasi cosa, risponde sempre con un sorriso. Qualcuno, forse la maggioranza, non abbassa il finestrino, è preso dentro i suoi pensieri, con lo sguardo lo fa sentire inutile, quell’indiano un po’ scuro venuto da chissà dove, perduto chissà dentro quale destino. Intanto è evidente che non basta più un manifesto con la foto di un pagliaccio e di un animale esotico: c’è bisogno di tanto altro per riempire un tendone.
Rivedo lo stesso ragazzo mentre porta la paglia ai cammelli. Non ha più la giacca rossa con i merletti oro un po’ sporchi, ma pur sempre segno di riconoscimento di una qualche nobiltà. Ora distribuisce paglia con una carriola il cui cigolio denota il consumo di un eventuale cuscinetto o forse la lentezza di un dado. I cammelli hanno perso il pelo sul dorso, sono nel periodo della muta, nascosta durante gli spettacoli da un drappo rosso che sembrerebbe quasi una sella e invece è il modo per far riconoscere a loro stessi che si stanno esibendo per degli umani che si divertono osservandoli da vicino, al semplice loro correre intorno alla pista e niente di più.
A sovraintendere alle mansioni giornaliere degli animali, di cammelli, cani, asini e bufali, c’è un rumeno che parla bene l’italiano. E si chiede come mai gli italiani abbiano così tanta difficoltà a imparare le altre lingue. Un po’ di presunzione – gli rispondo – oppure un blocco legato alla storia, poi decidi tu. Lui, rumeno cinquantenne, informato, deduttivo e intelligente conoscitore del mondo, vive senza telefonino, senza molte speranze. Mi racconta che è arrivato anni fa in Italia per vendere un’auto a un suo concittadino ed è finito a fare l’aiutante in un circo. Dorme in uno di quei vecchi caravan, dove all’interno ci sarà di tutto, dove non oso entrare.
Mentre parliamo, lui, il rumeno, coordina le diverse gabbie con piccoli passi di qua e di là, passano gli indiani con il mangime e poi arrivano le famiglie ad osservare il piccolo zoo, qualcuno usa fare una foto. Si può fare, dice lui, per quel che conta: entrare di mattina a guardare gli animali del circo è costato due euro a testa. Le sue considerazioni sul circo sono amare: senza il contributo statale sarebbe morto già da almeno dieci anni. Ora è in una perenne rianimazione. Mancano le bestie feroci, le vere star del circo, da sempre.
Alle 18 c’è il primo spettacolo, alle 20 il secondo, il sabato e la domenica. Vado con la mia piccola telecamera, nascosto un po’ dietro le quinte, con un permesso verbale, provvisorio, discreto e forse amichevole (in cerca un po’ tutti di contatti veri per parlare, non solo per esibirsi).
Mi saluta con grazia il clown Albert che nella realtà è un ragazzo di 16 anni, che prova a divertire il pubblico con poche scene semplici oppure fingendo di cantare “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri.
Ed è su questa canzone che non ho visto più il circo ma il mio mondo esterno, quello fuori dal tendone, la mia Europa.
Albert, il clown, con il suo naso rosso e la mimica espressiva che tradisce una timida grandezza, si trasforma in quasi il simbolo di questa ironica resilienza. A soli sedici anni, sa già come infondere in ogni gesto la speranza e il coraggio di chi, quotidianamente, si confronta con la precarietà di un mondo in trasformazione. I suoi momenti di comicità, tanto semplici quanto intensi – che a tratti ricordano le note struggenti di una vecchia canzone d’amore – diventano il canto di una generazione che, pur immersa nel duro lavoro e nelle certezze sbiadite, non ha mai del tutto smarrito il gusto del sogno.
Il circo che viene nel Salento, con i suoi piccoli numeri e l’insistenza di restare fedele a una tradizione ormai in declino, rappresenta un microcosmo in cui il passato e il presente si fondono. Le bestie, una volta star inevitabili dello spettacolo, ora si esibiscono in un’ordinaria “rianimazione” che testimonia, in maniera amara e sincera, l’incapacità di ricostruire i fasti di un tempo. Eppure, anche nella loro debolezza, esse raccontano di una bellezza imperfetta: il coraggio di andare avanti nonostante il tempo e le avversità.
Mentre il circo prosegue il suo itinerario tra le cittadine del Salento, tra maltempo e serate annullate, l’evento si rivela come un fragile rituale collettivo, l’ultimo baluardo di una cultura fatta di emozioni tangibili e di relazioni umane genuine. Che si tratti del ragazzo indiano che, con il sorriso sempre pronto, distribuisce biglietti e speranze, o del filosofo rumeno che con passi sommessi orchestra il caos delle gabbie, ogni figura diviene una metafora del destino di chi opera in territori dimenticati ma ancora pulsanti di vita.
In questo palcoscenico itinerante, il circo ci ricorda che non bastano più i manifesti con la foto patinata di un pagliaccio o di un animale esotico per colpire l’anima. Oggi serve un impegno autentico, un’attenzione ai dettagli—anche quelli più umili come la paglia distribuita o le ruote consumate dei vecchi camion—che riveli l’essenza della condizione umana.
Riflettendo sul percorso del Marina Orfei, non posso fare a meno di avvertire che, nonostante la desolazione di una terra desertificata e dei tempi incerti, vi è ancora una scintilla di vita che ribolle tra le pieghe degli schermi di fumo e polvere. È una sfida al progresso meccanico e alla logica della produttività fredda: un invito a credere che anche nella mera ripetizione quotidiana di un numero, l’arte è capace di strappare un sorriso, di risvegliare il sogno e, forse, di aprire la porta a nuove possibilità.
Il circo diventa così un’arena in cui si combatte contro l’ingiallimento dei giorni e la solitudine di un’esistenza troppo spesso vissuta in silenzio. Ogni figura – dal clown che canta in punta di piedi, dalla trapezista troppo giovane, all’acrobata troppo vecchio, alla bigliettaia che poi diventa domatrice di cavalli – è una nota in un’armonia precaria ma insostituibile. È il richiamo a non dimenticare che, dietro l’apparenza di uno spettacolo semplice e modesto, giace il potere distruttivo e redentore dell’arte che sa trasformare la fatica in bellezza.
In definitiva, il circo che si trasferisce da paese a paesino non è solo un avvenimento itinerante: è un simbolo del nostro tempo. Rappresenta la lotta quotidiana per mantenere vivi i sogni in mezzo a una realtà che spesso sembra aver dimenticato il valore della meraviglia. Il tendone, con le sue luci tremolanti e le ombre che danzano sui volti degli spettatori, diventa il palcoscenico di una rivoluzione silenziosa, quella dei cuori e delle menti che, nonostante tutto, continuano a credere in un domani diverso.
Nel fragore delle risate soffocate e nel rumore del passato che si intreccia al presente, risuona il messaggio: anche se il circo di una volta sembra svanito, la sua eredità rimane. E cioè quella capacità, quasi sovversiva, di farci sognare, di infiammare l’immaginazione e di ricordarci che, anche nella più grigia delle routine, la magia è possibile.
- Pubblicato sul bimestrale 39° Parallelo – aprile 2025
- Share